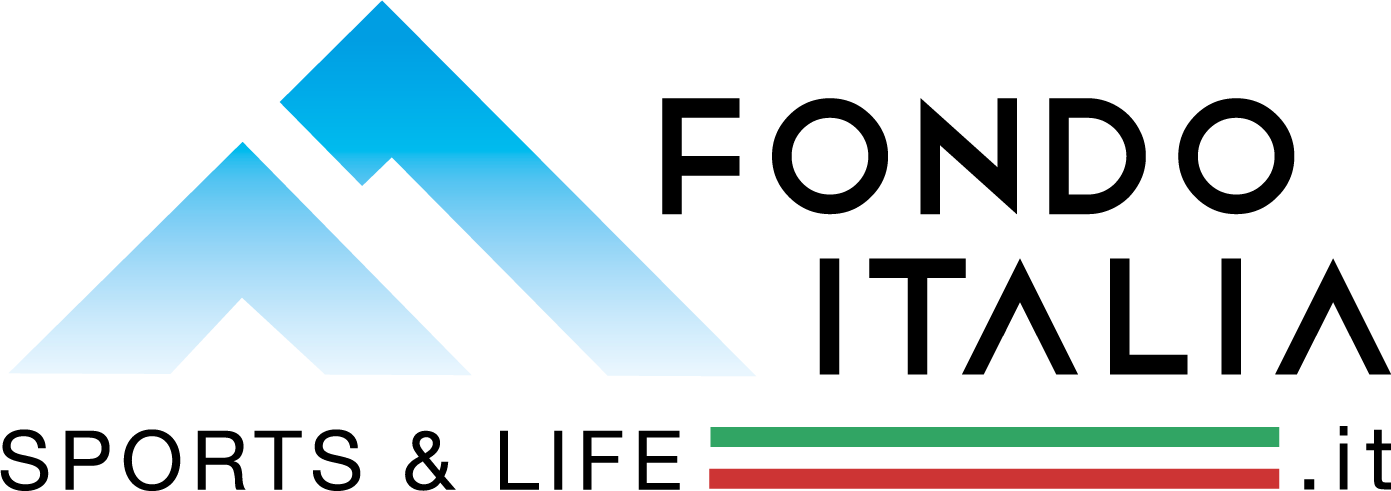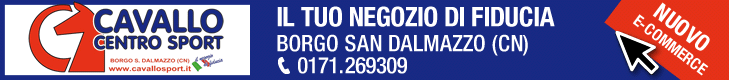Tra nove mesi circa il braciere olimpico si accenderà su Milano, Cortina e le altre località dell’arco alpino che ospiteranno le Olimpiadi invernali del 2026. Per quanto riguarda il biathlon, la sua sede sarà naturalmente il tempio italiano della disciplina, l’altoatesina Anterselva, che a 1600 metri sul livello del mare metterà a dura prova gli atleti.
Per questo motivo, negli ultimi anni le Nazionali hanno dedicato parte della loro preparazione estiva al lavoro in quota, per adattare il fisico ad un altitudine importante con quella della Südtirol Arena – che ieri ha visto il sopralluogo di SIMICO in compagnia di Dorothea Wierer a fare gli onori di casa – , dove bisognerà fare attenzione, ancor più che nell’annuale tappa di Coppa del Mondo, a dosare lo sforzo fisico in pista in previsione dell’impegno al poligono e dell’ancor più difficile giro finale, arricchito per l’occasione delle gare a Cinque Cerchi, di un nuovo affascinante – ma tosto – finale attorno al poligono.
In questi giorni, l’IBU ha realizzato un approfondimento sul tema sull’attualissimo trend dell’allenamento in quota, che non coinvolge solo il biathlon ma anche altre discipline sugli sci stretti – esplorando come gli atleti e più in generale le squadre nazionali si stanno adattando alle sfide richieste da un’Olimpiade “ad alta quota”. Dalla riduzione dell’ossigeno al suo impatto sulla frequenza cardiaca, sul recupero e sulla precisione di tiro, Biathlonworld ha parlato sia con coloro che dovranno mostrare in pista i frutti della dura preparazione, come gli atleti Sturla Holm Laegreid e Deedra Irwin, ma anche coloro che, dietro le quinte, aiutano gli atleti ad essere pronti per questo sforzo, dal medico di squadra Carolin Kilian agli allenatori Johannes Lukas e Jonne Kähkönen, rispettivamente del team svedese e del team italiano.
“Biathlon è uno sport estremo diverso dagli altri” spiega il tecnico Johannes Lukas “sei al 100% sulle piste, ma poi devi essere assolutamente caldo al poligono. Quando sei in quota a 1400 o anche più in alto, hai la sensazione che non ci sia abbastanza aria da respirare, e poi al poligono devi smettere di respirare, concentrandoti sui bersagli e questo naturalmente non è facile”
Non tutti gli atleti, come capita per esempio ad alcuni tra gli italiani e i francesi, hanno la fortuna di essere nati in quota o essere cresciuti agonisticamente in un impianto collocato oltre i 1400 metri s.l.m., ricordano Laegreid e Irwin: “La prima volta che ho gareggiato in quota” ricorda la statunitense “mi sembrava di muovermi a rallentatore. Non potevo affatto respirare. Il mio corpo era pesantissimo”.
Quello che accade al corpo in queste circostanze lo spiega il medico della nazionale slovena, Carolin Kilian: “Si deve fare i conti con un’elevata frequenza cardiaca submassimale e un aumento della frequenza respiratoria.” I Campionati del Mondo di Lenzerheide, con i tracciati che si snodano attorno alla Roland Arena tra un’altezza minima di 1389 metri e un’altezza massima di 1416 metri, sono stati un buon antipasto per l’evento clou del prossimo anno, permettendo agli atleti di lavorare sull’adattamento alla quota e alla messa a punto anche del più piccolo stratagemma o strumento possibile per capire come gareggiare, allenarsi e dare il meglio di sé alle altitudini più elevate ricevendone vantaggio.
Oltre all’adattamento alla quota, importante per esprimere al meglio del proprio potenziale in pista, è importante lavorare anche sul respiro, come fa notare il tecnico dell’Italia, Jonne Kähkönen: “La ventilazione è uno degli aspetti chiave per me, che voglio sempre esaminare e voglio insegnare agli atleti come cambiano dal livello del mare alla media e alta quota, in modo che possano fare questa esperienza prima delle competizioni più importanti.“
Dal punto di vista fisico invece, la curva di prestazione del lattato subisce uno spostamento verso sinistra e un meccanismo di compensazione più basso. Il vincitore della Coppa del Mondo fa notare che “la mancanza di ossigeno rende i muscoli doloranti molto presto. Arrivo subito al limite e di solito è per questo che ho una specie di sorriso, ma in altitudine non funziona proprio.”
Tutti sono concordi su una cosa: la chiave per provare a rendere al massimo è passare lungo tempo in quota, sia semplicemente vivendo che allenandosi oltre i 1400 metri s.l.m., cercando di personalizzare quanto più possibile il lavoro al fisico di ogni atleta che risponde in maniera diversa allo stimolo dato dalla quota. Non è un caso se, soprattutto in occasione degli ultimi Mondiali in Svizzera si sono visti tanti atleti lavorare lungamente al poligono, sperimentando opzioni diverse di gestione del respiro durante il tiro. Una parola chiave della gestione dello sforzo in quota, come già detto, è la personalizzazione. “L’esposizione alla quota è importante affinché gli atleti possano avere una sensazione personale di cosa accade al loro corpo oltre una certa altitudine” spiega l’allenatore degli svedesi, Lukas “e cosa devono fare sia nella fase di avvicinamento al poligono che durante i cinque colpi”.
E a tutto questo, non si può non aggiungere l’importanza del recupero: con il fisico più facilmente e più velocemente affaticato dallo sforzo fisico, diventa cruciale dotarlo delle energie necessarie, prendo il sonno, la nutrizione e l’idratazione con la massima serietà, soprattutto quando si gareggia.
“Certamente è importante è che tutti gli atleti siano esposti all’altitudine, ma alla fine, come dico sempre, la prima e l’ultima cosa è l’allenamento. Se l’allenamento non è a posto, se la periodizzazione dell’allenamento non è buona, allora giocare con diverse altitudini nella preparazione o durante il periodo delle gare, vivere in alto o vivere in basso, non fa alcuna differenza. Per me non ha senso.” conclude Kähkönen.